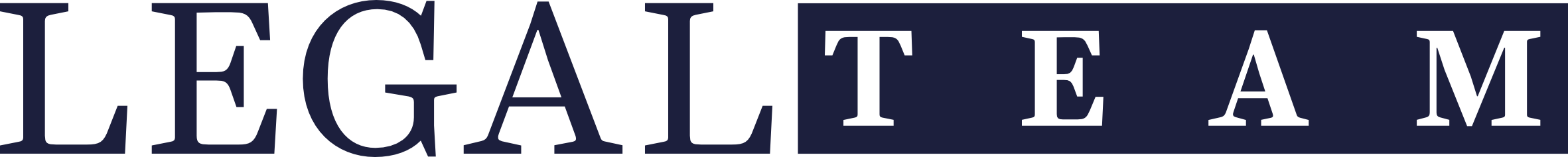L’approccio “timoroso” del Giudice Amministrativo alla ricostruzione, tramite ristrutturazione, degli edifici crollati o demoliti.
 Ne abbiamo parlato già qualche volta (ad esempio in questo video girato con l’ing. Carlo Pagliai ), ma il tema dell’interpretazione e corretta applicazione dell’art. 3, co. 1, lett. d), DPR 380/2001 continua ad essere oggetto di troppe “riserve” da parte del Giudice Amministrativo.
Ne abbiamo parlato già qualche volta (ad esempio in questo video girato con l’ing. Carlo Pagliai ), ma il tema dell’interpretazione e corretta applicazione dell’art. 3, co. 1, lett. d), DPR 380/2001 continua ad essere oggetto di troppe “riserve” da parte del Giudice Amministrativo.
Come sappiamo, tale norma, che definisce gli interventi ricadenti in “ristrutturazione edilizia” (e, quindi, non in nuova costruzione), prevede, tra l’altro, che tali sono anche “volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
La norma, introdotta ormai sei anni fa (con il d.l. 98/2013, “decreto del fare”) risponde alla finalità del recupero del patrimonio edilizio esistente, anche dismesso (o, come nel caso di interesse, “crollato o demolito”).
Fino all’introduzione di tale disposizione, infatti, era pacifico che la ricostruzione di un fabbricato diruto costituisse nuova edificazione e non ristrutturazione.
La (molto sintetica, in effetti) nuova norma ha inteso far slittare tali interventi di ripristino nella categoria della ristrutturazione edilizia (sottraendoli, in linea di principio, ai limiti normativi e pianificatori da rispettare in sede di nuova edificazione). Sostanzialmente, dato un edificio “crollato o demolito”, in tutto o in parte (lo dice sempre l’art. 3, co. 1, lett. d) il proprietario dispone di una sorta di “cubatura” virtuale, da poter ri-edificare senza che ciò configuri una nuova costruzione.
A fronte di tale novità (ma ormai non è più tale: risale al 2013) la giurisprudenza ha mostrato, e continua a manifestare troppo spesso, un approccio del tutto conservatore, così spesso vanificando la novità legislativa.
Si badi: un conto è il (giustissimo!) rigore sul tema della prova della preesistenza (che deve essere offerto con dati e documenti attendibili, specie quando si tratta di provare la consistenza di immobili allo stato fisicamente non più percepibili nelle “coordinate” principali), altro è continuare a reiterare la tesi (valide senz’altro ante d.l. 98/2013) secondo la quale
“la nozione di ristrutturazione edilizia non può prescindere dalla preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un fabbricato dotato di quelle componenti essenziali – murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura – idonee come tali ad assicurargli un minimo di consistenza ed a farlo giudicare presente nella realtà materiale. Con la conseguenza che la ricostruzione di ruderi, vale a dire residui edilizi inidonei a identificare i connotati essenziali dell’edificio, deve essere ricondotta nell’alveo della nuova costruzione, non rilevando in contrario la possibilità di risalire attraverso complesse indagini tecniche all’originaria consistenza di un manufatto oramai non più esistente come tale (…). Tale orientamento non è mutato neppure a seguito della novella apportata all’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 dal ricordato d.l. n. 69/2013, giacché, per potersi parlare di ristrutturazione, occorre pur sempre che i resti della costruzione crollata o demolita presentino caratteristiche tali da consentire di determinarne l’effettiva consistenza (..). Nondimeno, se pure si volesse ritenere che le modifiche legislative del 2013 abbiano esteso la nozione di ristrutturazione all’attività di ricostruzione dei ruderi, nel caso in esame il manufatto da ricostruire manca del tutto, essendone stata a suo tempo eliminata ogni traccia. Il che impedisce in radice di rinvenire nell’intervento in questione i contenuti della “trasformazione” di un organismo edilizio esistente, che, lo si è visto, rappresenta il tratto distintivo della ristrutturazione edilizia alla stregua della definizione generale dettata dall’art. 3 d.P.R. n. 380/2001″. Si tratta di un approccio che, portato alle estreme conseguenze, conduce – di fatto – a svuotare la novità normativa (insomma, se il Legislatore parla di “edifici crollati o demoliti“, come può tale affermazione conciliarsi con la pretesa di avere a che fare con un fabbricato dotato di murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura, ossia un edificio … non crollato né demolito?)-
Questo è, in particolare, quanto afferma la recente sentenza TAR Toscana, Sez. III, 22.2.2019, n. 286, sia pur in una fattispecie “al limite” nella quale – stando alla decisione – il manufatto oggetto di ripristino era del tutto assente ed invisibile (ma la norma parla di edifici crollati e demoliti, senza in vero imporre alcun livello di “fisica esistenza” dei resti).
Il tema della prova, come detto, non è in questa sede messo in discussione ed è quindi da condividere (in linea di principio) il successivo passaggio della decisione in esame laddove si rileva che:
“l’originaria consistenza dell’immobile da ricostruire neppure è stata adeguatamente dimostrata dai ricorrenti, la cui pretesa risulta pertanto infondata sotto ogni profilo. Del fabbricato demolito non vi sono rappresentazioni iconografiche, fatta eccezione per la planimetria allegata alla denuncia di variazione catastale presentata nel 1988, proprio a seguito della demolizione, che ne mostra l’area di sedime. A partire dall’area di sedime, i ricorrenti ricavano l’altezza massima del fabbricato dai travicelli della copertura ancora visibili nella muratura dell’edificio principale, per poi presumere che la copertura scendesse fino al termine di quest’ultimo con la stessa pendenza della vecchia copertura dell’adiacente porzione est. Il volume del fabbricato è ottenuto moltiplicando la superficie dell’area di sedime per l’altezza media (…). Come si vede, muovendo da un dato approssimativo, ma in qualche modo verificabile (l’ampiezza dell’area di sedime si può ricavare dalla misura delle pareti dell’edificio principale, in aderenza al quale era costruito quello crollato), il calcolo del volume finisce per essere frutto di un’ipotesi meramente congetturale, non essendovi elementi oggettivi dai quali desumere la reale pendenza della copertura originaria. E, oltretutto, non vi è prova che all’epoca della costruzione del fabbricato, poi demolito, la copertura utilizzata dal tecnico dei ricorrenti come riferimento avesse la medesima pendenza attuale (si tratta di porzione immobiliare ristrutturata nel 2013, stando alla stessa relazione tecnica di parte ricorrente, ma la consistenza delle opere di ristrutturazione non è nota). Se tanto basta per evidenziare la sostanziale arbitrarietà del calcolo volumetrico eseguito dai ricorrenti, a maggior ragione gli scarsissimi elementi disponibili non permettono di verificare il rispetto dell’identità di sagoma (…), requisito indefettibilmente richiesto dal citato art. 3 co. 1 lett. d) d.P.R. n. 380/2001 per gli edifici vincolati, ovvero ricadenti in area vincolata (…)”..
Tornando, invece, al tema di fondo, qui di interesse, merita invece condivisione (perché rispettosa dello spirito della norma come modificata nel 2013) quanto rilevato dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sez. IV, 27.9.2017, n. 4516, secondo cui se il privato allega prove serie su tale preesistente consistenza (atti di compravendita, documentazione catastale, rilievi fotografici, planimetrie), l’Amministrazione non può “liquidare” la pratica, ma è tenuta a valutare con attenzione (e motivatamente) quanto prodotto dal richiedente (non potendosi, dunque, limitare ad affermare che “il fabbricato non è fisicamente esistente”).
E ciò anche laddove tali elementi siano tali da dimostrare la preesistenza pur solo “in via deduttiva” e, addirittura, onerando la PA, se del caso, di riconoscere solo “una parte” della preesistenza provata. E ciò in quanto, precisa il Cons. Stato, un diverso approccio sarebbe non coerente “con la tutela delle facultates agendi del proprietario e con le disposizioni in tema di ristrutturazione edilizia“.